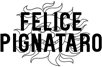to teach or not to teach. a napoli
voci
Da mercuriodeipiccoli, annoduenumerodue, aprile 2004, giannistoppaniedizioni, pag. 80
Forse la domanda era: che cosa dovrebbe dare la scuola? Che cosa dovrebbe dare a Napoli e a chi a Napoli vive, in che modo potrebbe attraversarne la complessità, e accettarla, senza per questo aumentare le difficoltà dell’esistenza?
Forse era questa la domanda, a casa di Felice Pignataro, quartiere Secondigliano, il 23 ottobre del 2002. A Secondigliano, se si cammina guardando dritto davanti, sembra di stare a Los Angeles perché si passa in mezzo a strade enormi, larghe come in nessun’altra zona della città. Invece si sta in uno dei quartieri più disagiati di Napoli, periferia Nord, zona Scampìa.
Insieme con la moglie Mirella La Magna, insegnante, Felice Pignataro cominciò a seguire le vicende dei baraccati nel 1967, con un doposcuola volontario in uno stanzone della scuola elementare “Paola Lombroso”, “per generosa concessione del direttore didattico.” Felice non era nato a Napoli ma in Puglia, però viveva a Napoli dal 1958, quando si era iscritto alla facoltà di architettura. Allora le strade non erano quelle di Secondigliano ma di Poggioreale, dove di fronte al cimitero stavano le duecento baracche del Campo ARAR. Poi, dopo un paio d’anni, i baraccati si trasferirono nelle case popolari di Secondigliano, e Mirella e Felice li seguirono, ed è lì, adesso, che sta ancora la loro casa.
“Quello che mia moglie e io cercavamo, al di là di tutto, era una continuità di rapporto, ma dopo un anno quello stanzone non fu più disponibile, e di nuovo ci trovammo senza un posto da cui cominciare. Intanto, portavamo avanti un’inchiesta sullo stato di istruzione nel campo delle baracche. Scoprimmo che si era chiuso da poco l’asilo d’infanzia a ridosso del cimitero e che non se ne sapeva il perché. Ci rendemmo conto che c’era parecchio analfabetismo, e sarebbe stata utile una scuola per adulti. Ci arrivarono poi molte voci di persone preoccupate per i figli, che non andavano a scuola oppure andavano male e venivano bocciati. Insomma c’era troppo da fare. E noi, in mancanza d’altro, ci installammo nella baracca numero 128, tre metri e venti per sette di blocchi di pomice di cemento. Lì facemmo il nostro doposcuola, la Scuola 128. ci eravamo fatti prestare dei banchi fuori uso. Nella baracca avevamo dipinto un grande sole. Volevamo fare quello che la scuola di Stato non faceva, occuparci di quelli che stavano più indietro e non andare avanti se tutti non avevano capito. Si apriva la baracca alle quattro del pomeriggio e si faceva il doposcuola ai ragazzi di seconda elementare fino alle cinque, poi fino alle sei e mezza si lavorava con quelli di terza e fino alle nove con quelli di quarta e quinta e delle classi medie. La prima elementare invece veniva il sabato, perché chiedeva più cura e più tempo. in tutto, più di sessanta ragazzi, che poi col tempo diminuirono un po’.”
Il doposcuola della Scuola 128 andò avanti fino alla fine degli anni ’70.
“Intanto erano nati i nostri figli, li avevamo mandati a scuola e provammo a collaborare con gli insegnanti dello Stato. Nell’edificio scolastico c’era un’aula con i proiettori, ma la porta era blindata. Chiedemmo di aprirla e ci mettemmo a oscurare le aule per proiettare diapositive, però presto si diffuse l’idea che fosse fatto buio per pomiciare con le maestre.
Fummo diffidati e fu allora che demmo vita al GRIDAS, Gruppo Risveglio Dal Sonno, e alla Casa delle Culture ‘Nuvola Rossa’, tutto con sede a Scampìa. Era troppo difficile partecipare dall’interno alle attività della scuola. Con il Gridas, allora, cominciammo a farlo dall’esterno. Intorno alla scuola, che era di pietra grigia, disegnammo dei murales. Cercammo spesso di collaborare con i maestri e gli insegnanti, ma difficilmente siamo riusciti ad avere con loro un rapporto. Ci siamo accorti che non sempre chi si trova a fare il maestro si preoccupa dei bambini. Molti vengono da fuori, vedono il territorio come una situazione temporanea, insegnano senza tener conto delle necessità degli alunni. Pensa che in prima elementare, dopo sette giorni di scuola, una maestra ha detto alla madre analfabeta di un’alunna che sua figlia era indietro. Da queste parti, in classe, senti dire ancora spesso che le bambine è inutile che studiano, tanto si devono sposare. Poi una volta è successo che un bambino non è andato a scuola perché teneva la visita. ‘Che avevi?’, gli ha chiesto la maestra. ‘Ma no, tenevo la visita al carcere a mio padre’. Alle medie, qui a Secondigliano, almeno 18 ragazzi hanno una situazione così. Si tratta di un vissuto che un insegnante non può non tenere presente.
Il vero problema è che la scuola è scissa dalla vita, mentre le scuole dovrebbero esser dei centri di aggregazione, non dei posti dove si insegnano nozioni, ma il germe della vita sociale. Noi cercavamo di lavorare coi ragazzi coinvolgendoli con tutto il corpo, non soltanto con la testa. Poi, come dicevo prima, cercavamo una continuità, una cosa difficile da conquistare con i ragazzi sottoproletari,vittime di una società che li ha collocati al margine e lì li mantiene e delle nevrosi dei genitori.
L’altro problema è quello dello stare nella scuola. Qui, a Secondigliano, si tratta di edifici che sono stati costruiti per essere scuole. Però poi, per esempio, succede che un edificio nato come materna viene usato per una scuola media, una scuola che per anni era rimasta dentro aule mobili, prefabbricati di cemento. Le scuole vere sono arrivate dopo le case. Poi le nascite sono diminuite, e le scuole sono rimaste per metà inutilizzate. Con la conseguenza che gli spazi qui ci sono – c’è persino una pista di atletica, ma non si usano. Noi volevamo rendere le scuole “centri propulsori di cultura” nel quartiere, collaborando con gli insegnanti, con i ragazzi, con i genitori. Però questa idea si è scontrata con i fatti burocratici e sindacali, con i progetti sempre troppo grandi o troppo piccoli. Facevamo i murales, sì, perché i muri erano scassati, perché già nella scuola non ci si abituava alla cura. Chi vuole insegnare qui deve avere invece la volontà forte di dedicarsi. Nella scuola si riflette la confusione e la malattia della società.”
Nel 1990, Felice Pignataro ha cominciato a collaborare con Franco Di Vaio, allora preside del Liceo Vittorio Emanuele e poi della scuola media Sogliano, vicino alla stazione centrale. Insieme hanno lavorato al Presidio Permanente in difesa dei minori e della scuola dell’obbligo, scambiandosi esperienze ed esponendo progetti educativi in alternativa a quelli del ministero, “che hanno la durata di un anno e non garantiscono la continuità. Il presidio aveva prodotto anche un libro bianco sulla inefficienza della scuola pubblica, e in collaborazione con l’Istituto degli Studi Filosofici aveva provato a far conoscere la realtà della scuola negli altri Paesi. Perché il vero problema, adesso e allora e sempre da quando sono qui, è che la scuola rimane corpo separato. E invece è il posto dove si tramanda davvero la cultura del luogo. Penso ai genitori, quando partecipano alla scelta di libri di testo editi quasi tutti al Nord. Penso al nostro gruppo quando leggiamo con i ragazzi, o invitiamo i nonni a raccontare loro delle storie. Perché non è l’istituzione che ci impedisce o ci spinge a fare le cose, è la capacità umana. Penso a Mirella, mia moglie, che sta anche dentro la scuola pubblica, e che nel doposcuola insegnava a scrivere. Faceva scrivere i ragazzi tutti i giorni, scrivere come si parlava, con la stessa facilità. Perché a lei, che insegna alle medie, dopo la scuola elementare arrivano i ragazzi che scrivono ancora con le lettere staccate. Alle scuole medie, comunque, qui dalle baracche ci vanno ancora in pochi. Ma non sono i ragazzi che evadono, è la scuola che evade il suo compito, se non è capace di aprire altre prospettive.”
Che cosa dovrebbe dare la scuola? Felice Pignataro, che a ogni inizio d’anno girava per le scuole di Scampìa a proporre i suoi laboratori, aveva le idee chiare: la scuola dovrebbe insegnare certo le cose primarie, leggere, scrivere e fare di conto, ma saper poi associare l’utilità del leggere alla vita quotidiana. Perché altrimenti si resta sempre separati, non integrati: da un lato, “quelli che sanno fare le cose della scuola”, dall’altro quelli che scassano, e devastano, e rubano tutto di notte.
[…]
[…]
L’idea di fermarsi a Napoli, nata e cresciuta con una gestazione lunga, era quella di raccogliere voci diverse, da contesti e da età diverse, ma tutte dentro o accanto alla scuola e tutte vicine a una politica del “fare”.
Poi, il 16 marzo 2004, Felice Pignataro è morto, un ano e mezzo dopo la nostra intervista, poche settimane prima che fosse pubblicata. Quel 23 ottobre, a Secondigliano, la casa del “pittore matto” era bellissima, colorata, piena di sole e di libri. Felice Pignataro non era molto ottimista quel giorno, raccontava la sua storia lamentando i fallimenti e le difficoltà; ma i colori, i murales, parlavano più di lui. Raccontavano di decenni trascorsi a rendere più lieve la vita dei bambini a scuola, dicevano di un’isola delle culture dove i ragazzi di Secondigliano imparavano a studiare e ad amare la musica, il teatro, la poesia, la letteratura. Attraverso più di 250 murales, realizzati spesso noprofit in Italia e all’estero, Felice dichiarava il suo ‘senso’: “pretendere di combattere, con le proposte di una cultura viva, l’incultura dominante e mortifera basata sul culto del denaro su cui prosperano i clan in questo territorio.”
Per combattere, a Napoli, Felice Pignataro aveva scelto di cominciare dalla scuola. e a lui dedichiamo questo “mercurio”, con affetto, con dolore, con gratitudine.
Federica Iacobelli