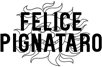Per una comprensione di Felice
Siamo stati tutti colpiti dal fatto che Felice sia morto dopo solo alcune settimane dall'incontro con lui, insieme agli altri amici del Collegio Newman. Sembrava di poter riprendere un filo interrotto trent'anni fa. E stiamo ancora riflettendo come si possa morire così, perché ci è parso sorprendente che le sue condizioni di salute siano precipitate tanto rapidamente.
Felice è morto povero, senza soldi, senza interventi di medici potenti, senza amici autorevoli al suo capezzale. Dal racconto della moglie, Mirella, è morto sereno, nel sonno.
E' morto povero nel senso elementare del termine, ma anche - credo - senza ideologia, stanco forse di averne una. Aveva lasciato andare quella soprannaturale e forse era piuttosto deluso da quella naturale, alla quale si era aggrappato; cioè quella politica che, nonostante tutto, praticava.
Agli occhi miei, e so che non è vero per tutti, si è consegnato nudo a Dio così come da Lui era stato creato. Quello che noi aggiungiamo alla morte è solo vanità.
La povertà, ai tempi del Collegio, della Fuci e della Cappella Universitaria, è stata una delle questioni più dibattute, un nodo da sciogliere per orientare le nostre scelte. Di quel dibattito oggi resta poco, ma sul corpo supino di Felice si è riaccesa la mia memoria. Chi avrei voluto essere? Uno come lui? O un borghese benpensante, con palazzi e villa al mare? Un politico rampante? Un professore tutto casa e scuola? E chi avremmo voluto essere noi tutti quando insieme alla povertà pensavamo alla comunità, sì proprio alla comunità, quella che è riapparsa per un attimo quando ci siamo rincontrati qui a Calitri.
La povertà evangelica era una beatitudine e ci appariva bella, pura, alla luce del Concilio e delle letture che facevo: Silone in primo luogo e poi Don Milani. Tuttavia non bastava apprezzarla. Ci si chiedeva se la povertà materiale fosse più radicale e più vera di quella spirituale. La condizione operaia, di povertà reale, sembrava un modello. Ma anche la povertà contadina, da cui venivamo quasi tutti, cioè la povertà della gleba o della «zolla», come si diceva al Collegio. Qualcuno preferiva quella operaia a quella contadina, credendo che la seconda fornisse meno vocazioni alla lotta di classe. E, su questo, si potrebbero trovare anche oggi argomenti per litigare, riaccendendo le ostilità delle concezioni di quel tempo.
Per farla breve, la povertà di spirito era democristiana, quella materiale era marxista.
E la ricchezza, cosa voleva dire aspirare alla ricchezza? Devo dire che non era un modello esplicito a quel tempo. Solo pochi la ponevano in modo chiaro tra gli obiettivi da raggiungere. Ma un futuro ingegnere o medico, non dico un professore, non la scartava a priori. Anche uno studente di architettura, qualora si fosse affermato avrebbe dovuto misurarsi con essa. E Felice decise di non voler più diventare architetto, forse anche per questo.
La povertà di Felice è stata povertà materiale, per il rifiuto di farsi vincere dalla materia. Ma non era povertà di spirito nel senso banale del termine, cioè non era dimesso, accondiscendente o scarso di idee. Tutti lo ricordiamo quando prendeva a cuore un problema e si scaldava. Quante volte, tornando la sera al Collegio, di cui era l'amministratore, si metteva a lavare i bicchieri o i piatti lasciati sporchi da qualcuno di noi, perché si sentiva responsabile della conduzione generale della comunità! Lo faceva borbottando o gridando contro i colpevoli di quel disordine.
Era 'na capa tosta, e si sapeva, ma con quella testa partoriva idee irrefrenabili.
Curiosamente, lui, invece, possedeva la materia; perché come artista doveva saperla dominare. Se giro lo sguardo della mente nei luoghi in cui lui stava, non vedo altro che attrezzi di lavoro di falegname, colori e pennelli, sacco e tele, ferro filato, legno, oggetti recuperati dalla spazzatura, materiale di scarto diventato arte. Vedo anche i libri di teologia, ordinati ben bene sul tavolo da lavoro del salone del Collegio, un luogo in cui erano esposti gran parte dei suoi quadri. Nella sede della Fuci in Via Tarsia, rivedo un crocifisso gigante in tondino di ferro sagomato a mano.
Lavoro solitario il suo, con l'unica compagnia della sigaretta. L'accendeva e la infilava nell'angolo della bocca, riponendo con un gesto rapido il pacchetto nella tasca della camicia militare di cui si vestiva, e l'aspirava voracemente. Lo stesso gesto mi torna in mente quando, nel Collegio, la sera spiegava a qualcuno di noi le Scritture. Penso che nessuno dei suoi colleghi studenti alla facoltà teologica di Capodimonte poteva immergersi nelle questioni della fede con uguale intensità. Felice, infatti, aveva rinunciato ad un mondo in cui poteva diventare «qualcuno» per essere quel che la sua testa gli suggeriva, seguendo Padre Bruno, seguendo il Vangelo con radicalità e principalmente la sua bellissima vena artistica.
Il pavone che egli ha dipinto sulle pareti di casa mia con pennellate rapide e gioiose e che vi campeggia ancora, dopo otto anni, insieme al bruco «sifilitico» mi ricordano ogni giorno quella vena sorprendente. Qualcuno che li ha visti solo in fotografia ha detto che sono lo specchio di un'anima ricca.
Dunque, Felice era «ricco»! Certamente arricchiva chi scrutava la sua anima, attraverso i disegni, le pitture, le incisioni a fuoco su legno, gli oggetti colorati, i murales politici con cui si faceva beffe dei potenti o le caricature della gente comune come quelle, ad esempio, delle infermiere con le tette grosse, nel reparto maternità dell'Ospedale di Villa d'Agri. Su un biglietto da visita da lui stesso stampato al torchio, egli aveva scritto: Felice Pignataro, Genio, via Appia 213, 80144 Napoli. Un modo per dire eccomi qua, autocosciente delle abilità che solo lui aveva.
Ma di recente lo tormentava la sconfitta. I suoi progetti gli apparivano sempre più lontani dalla realtà del mondo in cui viveva, quel mondo della Napoli abbandonata, nella quale aveva scelto di accendere la luce della sua presenza. Non so se avesse degli amici veri e se la sua generosità fosse condivisa nel profondo da qualcuno, oltre che dai suoi cari. A me non l'ha voluto mai confidare, anche se in una lettera del maggio 2003 mi scriveva :«io continuo a spennellare qua e là senza convinzione della mia azione».
D'altra parte la mia scelta era stata diversa dalla sua, avevamo concezioni non simili dell'impegno sociale e politico. Se ho preferito vivere in una campagna a Calitri, più che in una città complessa, o soprattutto in una periferia urbana in cui la gente è senza lavoro, senza ordine, senza tutela, è perché ho rifiutato fin da ragazzo quel mondo a me incomprensibile. I vertici di una figura geometrica regolare, da ripetere ogni giorno, da casa a scuola, al centro del paese, presso i miei genitori e qualche amico mi apparivano più logici che l'andare su è giù tra mare e collina, nel caos di una metropoli bella ma dura come Napoli. Ho sempre sofferto la condizione di inferiorità rispetto a lui e a Mirella. Capivo che essi erano persone coraggiose ed io, invece, no! Comunque, scegliere la zolla, il luogo natio, l'ambiente contadino, non è stato meno degno per me, forse solo meno eroico.
Felice mi aveva capito. Sapeva che io ero autentico nel rispetto della manualità. Sapeva che la mia ammirazione per lui era spontanea e che era garantita dall'essere figlio di un padre artigiano e contadino, la cui serietà non ha bisogno di essere precisata da alcuna collocazione politica.
Ho pensato a Felice come all'esemplare dell'uomo capace di esprimersi sia con la mente che con le mani e l'avrei volentieri portato a modello nei luoghi in cui discuto sulla concezione del sapere e della scienza. Ma Felice non si lasciava catturare.
Non ho capito bene se egli avesse rimosso l'esperienza del Collegio oppure la considerasse ancora al centro della sua vita, come è capitato di scoprire a molti di noi, proprio l'ultima volta che l'abbiamo visto. Sono sempre stato convinto che solo lui avesse le capacità di scrivere e lasciare una traccia storica del Collegio. Se non l'ha voluto fare è forse perché quel ricordo non lo metteva a suo agio.
Mi confidò per telefono, circa un mese fa, che aveva cominciato a scrivere l'autobiografia. Mi sembrò anche disposto a riprendere insieme a noialtri la riflessione sul Collegio. Ma capii che l'avrebbe fatto solo se invogliato, non perché ne fosse entusiasta.
Il Collegio è stato secondo me un evento eccezionale, con i grandi pregi e i grandi difetti di eventi di tal tipo. E' stato generato dalla Fuci, segnato dalla novità del Concilio ed esposto all'effervescenza di varia natura delle idee dei movimenti studenteschi dal '68 in poi. Non lo si può descrivere senza soffermarsi su via Paladino, quel luogo nel cuore di Napoli dove ebbe la fase matura, e su quel periodo storico, tra la fine degli anni sessanta e gli inizi dei settanta. Fu una Istituzione ben nota, a due passi dall'Università. Leggendo le pagine di tanti cronisti napoletani degli ultimi anni, però non mi è mai capitato di trovarne menzione, forse perché i protagonisti del Collegio furono ragazzi non napoletani, provenienti da varie regioni meridionali, e un prete inglese.
Ma perché qualcuno oggi dovrebbe mai scrivere del Collegio, perché parlarne ancora se sono trent'anni che non esiste più?
Perché nel Collegio si è fatta esperienza di tutto ciò che era, al momento, la frontiera del pensiero: la comunione dei beni, la critica al potere mediatico della televisione, la riflessione esegetica dei passi biblici, la discussione politica delle radici della democrazia e dell'autoritarismo, la pedagogia dei poveri, le aspirazioni a un futuro più giusto, la crescita delle coscienze individuali contro il dogmatismo politico e religioso, Fabrizio De André, l'ironia, l'arte e l'anticonformismo. E poi perché credo che ci sia l'obbligo morale di ciascuno dei protagonisti di quella comunità di parlarne alle nuove generazioni.
In ognuna delle sfaccettature del Collegio a cui ho accennato c'era l'estro creativo di Felice. A lui si addice davvero la parola Utopia, una utopia concreta oltre quella che lui ha dipinto sui muri. Naturalmente, passato quel periodo, molti di noi sono stati riassorbiti dalla condizione borghese, ma non senza far germogliare quei semi.
A me rimangono nella mente alcuni suoi gesti, le risate caratteristiche e gli occhi stretti come fessure, l'andatura di ciclista senza bicicletta, dondolante a destra e a sinistra, il gesticolare con le mani per raccontare meglio i fatti, il pollice e l'indice uniti come certi conferenzieri di cui si voleva schernire.
Nelle curve dolci dei colori che spalmava sulle tavole e sulle tele ho visto riflettersi i miei sentimenti mentre cambiava la mia vita, i miei legami con gli amici di Calitri, le mie scelte per il futuro. Come se fossero le equazioni differenziali di una legge interiore, quelle curve riaffiorano ogni volta che, scarabocchiando con la penna, tento di seguire il mio pensiero più vero. C'era sempre un andare avanti, diritto, uno svoltare e un ripartire e un tornare ancora indietro, prima di ricongiungersi, più in là, all'impulso iniziale.
Un profondo respiro mi trattiene staccato da tutto il resto, dopo aver scritto queste parole.
Pietro Cerreta