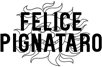Disperata allegria
Chi era Felice Pignataro e perché ne parliamo qui? Pittore di formazione e vocazione, approdato a Napoli dalla Puglia (San Vito dei Normanni) più di trent’anni fa, è stato tra i protagonisti di molti “cicli di lotta”, come si diceva un tempo, insediandosi con la famiglia a Secondigliano-Scampia e lavorando indefessamente, con ostinazione e pertinacia più uniche che rare, per il riscatto delle periferie. Ha organizzato manifestazioni e feste (e nella parola manifestazione è compresa la parola festa), ha organizzato soprattutto gruppi di bambini che hanno imparato come lui a dipingere murales colorati, ariosi, luminosi. Ha fatto tante altre cose, come i famosi (a Napoli) Carnevali di quartiere “a tema”, o le “televisioni a mano” che erano rapide azioni teatrali di strada, anti-televisive. Il suo punto di partenza era però sempre quello: il quartiere-città della periferia, più mosso e meno tragico di quello che la cronaca nera ha voluto sempre descrivere, ma certamente, “a ore più o meno fisse” secondo Felice, era luogo di lotte e prepotenze camorristiche.
Nella memoria collettiva di quella parte della città che non vuole rinunciare ad avere una memoria, e non è certo quella maggioritaria, né quella politica, Felice è però anzitutto i murales che con i ragazzi del Gridas (Gruppo risveglio dal sonno, fondato nel 1981) ha ininterrottamente proposto sui muri di scuole chiese strade, e che non hanno nulla da spartire con i brutti e devastanti scarabocchi degli imbrattamuri su cui qualche sconsiderato prof abruzzesiano ama commissionare tesi ad allievi dopati. Ma per chi ha lavorato a Napoli “nel sociale”, e ha dedicato parte della sua vita e del suo tempo al riscatto di un “sottoproletariato” e di una città avviliti dalla pessima modernizzazione bassoliniana e dalla presuntuosa vuotaggine jervoliniana – dalla mancanza di morale e della serietà della sinistra, nello specifico caso di Napoli dagli anni novanta che sembravano di dirompente speranza e sono stati, non solo culturalmente, di colpevole codismo e conformismo verso il peggio delle mode e degli interessi detti “collettivi” – l’insegnamento principale che Felice ha lasciato è quello della continuità e del radicamento.
Non è stato facile per lui e per il suo gruppo resistere tutti questi anni nello stesso posto, sopravvivendo a più generazioni di “militanti” di “volontari”. Da questa ostinazione nasceva, credo, quella sorta di disperata allegria che lo distingueva, tra tenerezza e sarcasmo. Felice non si è sradicato, negli anni settanta del “primato della politica”, quando anche le esperienze del volontariato di allora dovevano sottostare alle logiche strumentalizzatrici dei partitini e dei partitoni, ugualmente verticistici e leninisti, e poi negli anni dell’abbandono quando, con la caduta dei movimenti, tutti se ne andavano di qua o di là o si riciclavano professionalmente e mettendo su famiglia, e infine nei novanta che sembravano all’inizio di grandissima speranza e sono stati la sconfitta definitiva della speranza di “un’altra politica”. Ancora per colpa prioritaria della politica, Napoli bassoliniana ma per estensione della sinistra tutta, soprattutto quando andò al potere e con incredibile superficialità e stupidità si affrettò a corrompere e a castrare quanto di meglio il “sociale” dava in fatto di movimenti, associazioni e proposte, trovandoci supini e stupidi, pronti a rinunciare alla propria storia per il piatto di lenticchie di blande promesse economiche e l’offerta di minuscoli sottopoteri.
La qualità precipua di persone come Felice, in rapporto a tutti gli altri che si sono dedicati all’intervento sociale in una città molto confusa e lacerata da guerricciole di bande (corporazioni e partiti e lobbies e associazioni e gruppi dell’occulto), è stata dunque quella della durata. Non è poco, anzi è tantissimo perché, prima o poi, tutti ci siamo stancati, abbiamo subìto il logorio dell’esperienza e delle sue difficoltà e sconfitte e il richiamo di una vita più ordinata e sicura, il ricatto degli affetti primari. Felice ha resistito fino alla morte, e sino forse a morirne e ha pagato tutti i possibili costi di questa resistenza, di questa solitudine.
È importante riaprire continuamente il discorso sull’autonomia delle esperienze di intervento di base che puntano al “ben fare” e non si pongono il problema di “conquistare le maggioranze” andare al potere o di mandarci qualcuno dei loro leaderini sulla scia delle grandi manifestazioni periodiche e della loro personale spinta a “emergere” – nel meglio, della loro convinzione che solo entrando nel giro dell’alto si conta qualcosa e si può riuscire a cambiare qualcosa e, nel peggio, della loro capacità di intrallazzo.
Riassumo le convinzioni che in molti di noi sono maturate esperienza dopo esperienza. Quelli che seguono sono, credo, i tre nemici principali dei gruppi di volontariato, delle associazioni dell’intervento sociale, pedagogico, culturale a Napoli e ovunque:
– La politica. Si è subìto il ricatto della politica negli anni settanta, senza riuscire a trovare una sufficiente autonomia e identità nelle esperienze che non fossero immediatamente politiche né finalizzate alla politica. Allora la politica era nei gruppi, da Lotta continua al Manifesto a tutti quanti. Negli anni novanta, quando il discorso di base era ripreso con più vigore, ed era tra le poche cose veramente “politiche” che ci fossero, il ricatto della politika è servito in modo ancora più massiccio a condizionare, depotenziare e deviare iniziative grandi e piccole, e si è chiamato principalmente Ds. Accettando l’ambito imposto dalla politika, si è finito per non contare più niente, per perdere di autonomia, necessità, identità, vigore. Per entrare, senza spicco alcuno, nel calderone della politika con la scusa che solo questo avrebbe modificato davvero e velocemente le cose, dall’alto, non più dal basso.
– L’istituzionalizzazione delle esperienze. Vecchia storia e noti disastri: si finisce per porre al primo posto la vita dell’istituzione che si è creata, con relativi posti o posticini di lavoro, rispetto ai suoi oggetti, ai suoi destinatari, al suo scopo, alle sue idealità.
– La deriva di un malinteso individualismo. Cadendo i movimenti, come ha ben analizzato a suo tempo Christopher Lasch, si è caduti tutti in una sorta di “narcisismo di massa”, e nelle associazioni e gruppi è diventato enormemente più faticoso lavorare insieme. Mettere d’accordo più persone su un progetto anche minimo sembra ormai una impresa utopistica, figuriamoci più gruppi; tutti vogliono essere, con varie scuse e giustificazioni, egocentrici “figli di principi” e nessuno “figlio della serva”. Questa incapacità è oggi, mi pare, il nemico principale, la causa prima della morte precoce o dell’irrigidimento di tante benemerite e promettenti esperienze.
In conclusione, Felice Pignataro è riuscito a non farsi trascinare in questi vicoli ciechi, ma pagandone tutti i costi. È da esempi come questi che bisognerà ricominciare, rivendicando fino in fondo identità, l’autonomia, la dignità e il valore del “ben fare” – anche limitato, anche “impolitico”. E se da queste iniziative fosse necessario, come sarà, far nascere un coordinamento, esso dovrà essere di pressione sulla politica e non di ingresso nella politica, non di supinità ai politici o di complice adesione all’abbraccio mortale dei politci di mestiere. Che mai sono stati così dannosi e, a ben vedere, così inutili e impotenti di fronte ai veri poteri.
Goffredo Fofi
da "Lo Straniero", vol. 48, Ed. Contrasto DUE, 2004